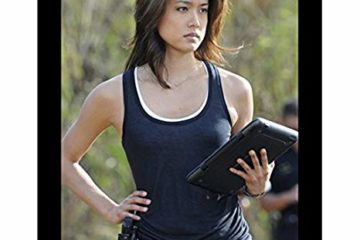Finalmente torniamo a casa.
Ci arriviamo in totale silenzio. Non una parola lungo il tragitto. Anche, se ad essere sincera non ricordo di aver percorso alcun tragitto.
Che strano, la casa non è la nostra casa di oggi né quella di ieri, lasciata a fatica con un trasloco infernale. So che è la nostra casa pur non riconoscendola affatto, anche perché non è nemmeno propriamente una casa, ma mi accorgo che è un intero borgo: queste sono le stanze, pur non essendo le stesse stanze, la mia mobilia, pur non essendo la stessa mobilia.
Era tanto che non tornavamo a casa. Tuttavia, non ricordo dove fossimo prima di tornare a casa. Questa casa, che ora è un borgo medievale vagamente recintato di molti dubbi, ha solo due entrate, con due serrature piccole e stupidissime e di certo non consone a proteggere tale struttura. Tu hai le chiavi e sono chiavi di volgare latta sottile. Ce ne sono quattro per la precisione: due più grandi e due più piccole. Si piegano ad ogni tornata. In pratica, capisco che dureranno ancora una girata e poi saranno inevitabilmente spezzate nella serratura. E noi saremo alla mercé di qualsiasi insidia.
“Non è per niente sicura questa casa. Bisogna fare qualcosa! E subito!” dico stizzita.
Tu non mi senti nemmeno e io inizio a montare ansia insoluta e molesta.
Mi sento negata l’attenzione a qualcosa di grave che mi pare così palesemente logico.
Sono stanca morta dal viaggio. Quale viaggio? Ma non appena entriamo, arriva della gente che scampanella insistente.
“Ecco, te lo avevo detto che questa casa non è sicura, a partire dal portone di entrata in giardino! Qualcuno è entrato!”
Brontolo mentre vado ad aprire. Tu non rispondi. Più che un dialogo è un monologo.
Sono i vicini, che, in teoria, dovrei conoscere ma che non riconosco. Eh, ma non si può essere scortesi…
“Prego entrate vi faccio strada.” Ma la strada pare la conoscano bene. S’infilano decisi come se conoscessero il posto meglio di me.
“Quanto tempo!” esclama la signora mora ricciuta sulla cinquantina.
“Già quanto tempo! come state?” La mia risposta è di convenienza. È retorica pura, perché non me ne frega niente, tanto sono stanca e nemmeno conosco questi vicini che dovrei conoscere e che son vicini di lunga data. Il perché sappia che sono vicini di lunga data, non mi è dato sapere. E nemmeno il perché non li riconosca come tali.
“Entrate. Vi posso offrire qualcosa?” E spero non vogliano niente ché non sono in vena.
Ma essi non vogliono quel qualcosa, cercano un altro qualcosa che non mi è chiaro. Si imbucano in tutte le stanze come dei segugi e io mi sto irritando: sono troppo stanca e sporca e il mio vestito è persino al contrario! Sono stizzita e non voglio persone intorno e, soprattutto, che mi vedano così.
Devo cambiarmi!
Te li affido con un misto d’ansia e perplessità per vigilare sulle loro scorribande. Accetti mal volentieri e mi infilo in camera…la mia camera, che non è la mia camera, ma è una stanza dove il tempo scorre diversamente che fuori. Infatti, il cambio di abiti diventa cosa lunghissima, o almeno credo perché fatico a muovermi in questo alternativo fluire del tempo non convenzionale, anche perché non so cosa mettermi: come sempre, ma diversamente da sempre. Di tutti i vestiti che ci sono, nessuno mi sta, nessuno mi piace ed è tutto un metti e leva. Forse, anche perché non sono nemmeno i miei vestiti.
Quando esco, più o meno raffazzonata con qualcosa che poi è esattamente quello con cui sono entrata, fuori è il delirio: casa nostra è diventata un una cittadella il giorno di una sagra campestre. Oltre alla coppia di presunti vicini di lunga data, si sono aggiunte almeno un altro centinaio di persone: adulti, bambini, vecchi. Crocchi eterogenei che fanno bisboccia e si dedicano alle più disparate attività ludiche e ricreative. Incluso un raduno improvvisato di improbabili cani brutti e malconci di piccola taglia. E tutti, cani inclusi, pisciano ovunque nei miei due bagni. Nessuno sa chi sono, né io riconosco alcuno, se non fosse per delle voci che provengono da quello che capisco essere un torneo carbonaro del raviolo fritto: riconosco la voce femminile che incita i concorrenti e poi inizia un conto alla rovescia per decretare la fine della prova. La riconosco, ma, nello specifico, non so a chi appartiene.
C’è sporcizia in ogni dove e persino un barbone seduto in un angolo del porticato: ha capelli rasta brizzolati, non propriamente realizzati di proposito, barba incolta di mesi e mi saluta con a mano. Praticamente, l’unico che pare riconoscermi. Non capisco cosa dice perché sproloquia ed è senza denti. Quindi se anche ci fosse un barlume di senso nelle sue parole biascicate, esse sarebbero incomprensibili.
E mi sento sempre più sola.
Ad un certo punto, qualcuno mi mette in guardia: il portone d’accesso, ovviamente quello all’ estremità opposta della, chiamiamola, proprietà, è rimasto aperto.
“Devi stare attenta! Le porte esistono per essere aperte, ma soprattutto chiuse,” sentenziano in coro degli anziani seduti su tre sedie impagliate, le cui gambe storte sfidano la legge di gravità. Ma non so chi siano, né pare essi mi conoscano, pur indirizzandosi a me come se fossi la tenutaria.
Allora, allarmata per paura che entri ancora qualcuno, ti lascio ad intrattenere gli ospiti ficcanaso.
“Non sei preoccupato?” ma è come se tu non mi sentissi.
Anzi, non mi senti proprio. Nemmeno mi guardi.
Prendo le chiavi di latta dal tuo giubbotto e mi incammino da sola e di gran lena per raggiungere l’ingresso incustodito. Dicono che ci vorrà circa una giornata intera di cammino…
Dal punto tu sei qui di un grande cartellone posto all’entrata, al punto tu sarai là, (quella verosimilmente incustodita) si dipana un percorso piuttosto irto e complicato: un prato incolto con passaggio su un acciottolato ormai fagocitato dall’ erba, che non è erba ma salicornia lagunare, quindi irriconoscibile, ma soprattutto senza alcuna utilità; un sentiero alberato con buche profonde come i buchi su Marte e addirittura un percorso ad ostacoli con giochi per bambini che però vista la letalità non sono propriamente adatti ai bambini. Infine, una pertica di ferro sulla quale dover salire ginnicamente per proseguire sul secondo livello del sentiero che si districa attraverso un fitto roseto di rose giganti incolte e mezze appassite, ma con delle spine grandi più degli aculei dell’istrice gigante, nelle quali si impiglia ora il cardigan ora i pantaloni. Sulla pertica, faccio a gara con una baby gang di ragazzini in fila che indugia senza fretta, che invece è tutta mia. Ma invece di irritarli con “levatevi di torno, ho fretta!” cerco di amicarmeli al volo, affinché non distruggano nulla di questa mia casa che non è una casa e forse, inizio ad avere il dubbio, non è nemmeno mia. Il più piccolo di loro sta spacciando sterco di mucca in bustine, in bilico sulla pertica come una lap dancer. Me la cavo con la promessa di regalargli tutta la mia vecchia collezione di macchinine di ferro. Pare funzionare e si levano di torno.
Proseguo e, mentre corro, impigliandomi di qua e di là nel roseto (e io che mi preoccupavo di non essere presentabile. Ora sono a brandelli), mi guardo in giro: cariole addobbate per la sagra con paglia, forche, damigiane, tavolini grezzi e mensole arraffate che espongono ninnoli e amenità varie di legno, vetro e ceramica, chiaramente mercanzia da baratto o da lotteria e chiaramente prelevati da casa mia. Anche se non ne riconosco nemmeno uno. Che gusto osceno. Sono orripilanti.
Tutta questa moltitudine, beve, mangia, grida, canta, gioca a carte e, ovviamente, non si cura di me. Io cerco di spiegare chi sono, ma nessuno mi riconosce. Allora tiro fuori il cellulare per chiamarti e spiegarti cosa sta succedendo qui fuori, ma non c’è nemmeno il tuo numero in rubrica e io non l’ho mai imparato a memoria. Se è per questo non c’è nemmeno campo. L’unico campo è quello dove un sacco di gente sta facendo bisboccia sull’erba incolta. La mia erba? E allora mi metto a urlare il tuo nome “Ludovico! Ludovico!” ma il suono non esce e lo urlo fino a che si gonfiano le vene del collo, ma niente. Ecco, non sai niente e non mi potrai aiutare a rimettere ordine a questa dimora aperta che fa acqua da ogni lato e invasa da orde di curiosi che saccheggiano le mie cantine con le volte a botte e che, tuttavia, a guardarle bene non sono le mie cantine.
L’unico volto conosciuto è la mia amica Palma di Roma, seduta su una sedia da osteria che sta amabilmente intrattenendo gli astanti. So che aspetta me. Lei mi sente, mi capisce e mi riconosce quando parlo e dico “Ti stavo aspettando!” Dice che è arrivata da poco, “Aò, n’ arzataccia, bella mia!” ma che ormai era lì e di fare con comodo. Cosa non so ma tanto ormai so poche cose di quello che succede qui.
Raggiunta l’apertura nord, o sud, dipende dai punti di vista e qui sono più dei punti cardinali, mi accingo a chiudere la porta con le chiavi che, ovviamente, si rompono nella toppa. La porta non si chiude e rimarrà aperta. E il popolo invasore continua a defluire all’interno stanziandosi a nord e sud e in altri punti cardinali che intanto si sono moltiplicati. Inizio a pensare che dalle porte d’ingresso si possa solo entrare e non uscire.
Ala fine, mi decido e torno al punto di partenza. Almeno, la mia partenza. Stesso giro stessa corsa. Stesso percorso accidentato per il borgo dai percorsi tormentati, pertiche, accampamenti goliardici e sentieri senza sentiero. Adesso stanno anche allestendo un falò per la festa serale; quando farà buio. Quindi penso: “è chiaro che non se ne andranno tanto presto”.
Accelero il passo nel percorso speculare e mi rammento di aver dimenticato le macchinine. Per fortuna i ragazzacci non ci sono più. Arrivo provata al punto di partenza e non ci sei più nemmeno tu e la stanza del tempo lento è diventata una piazza con pozzo. Ti cerco e non ti trovo, ti chiamo “Ludovico! Aiuto!! Ludovico! Ludovicooo!” Sempre più forte, ma la voce non esce.
Mi sento impotente: ovunque tu possa essere, non mi sentiresti comunque.
So che non è colpa tua, ma inizio a provare un rancore così forte per non trovarti e non riuscire a parlarti, che mi si accartoccia il cuore nel petto e potrei morire. E più il rancore cresce più il cuore è una pallottola di carta straccia. Urlo “Ti odio! Ti odio!” Ma ovviamente tu non puoi sentirmi, perché lo urlo solo a me stessa.
Ci sono solo io.
Non c’è più nemmeno la gara di raviolo fritto con il profumo di olio e burro sul fuoco, né i gridolini che accompagnavano questo circo gastronomico, fino a poco fa.
Quando mi sveglio, sono sudata e mi viene da piangere. E allora piango.
Dormivo così profondamente che ho mancato la fermata del treno. Ora non so nemmeno dove mi trovo. Non riconosco il panorama.
Cerco il cellulare in tasca per chiamarti e spiegarti e invece del cellulare, mi ritrovo in mano delle chiavi di latta che non ho mai avuto.
E nessun cellulare.