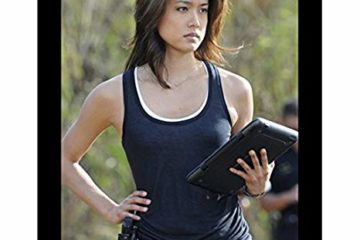(di Stefania Contardi, brano tratto da “Racconti Liguri”, Historica Edizioni, 2018)
 TORNARE A GENOVA E’ DIVERSO
TORNARE A GENOVA E’ DIVERSO
La fenice Superba riemerge sempre dalle ceneri. E’ il mare, capace di spazzare via la nebbia delle solitudini.
Solitudine. Condizione e sentimento nei quali l’individuo si isola per scelta propria (se di indole solitaria), per vicende personali e accidentali di vita, o perché isolato o ostracizzato dagli altri esseri umani, generando un rapporto (non sempre) privilegiato con se stesso. (liberamente tratto da Wikipedia)
Le parole sono importanti. I fatti a volte sono una valida alternativa, perché temo che ogni epoca perda per strada alcune parole. Perde le parole che non pronuncia più e non pronuncia più le parole che perde. Quello che non si sa bene è quale perdita avvenga prima. Sta di fatto che così si perdono anche le cose: il Sogno, la Meraviglia, la Libertà, la Fiducia, la Bellezza e il suo Rapimento, la Poesia, l’Amore, l’Ordine, eccetera, eccetera. L’elenco è lunghissimo. Una volta perse queste parole, se ne va anche la loro natura più intima, perché il disuso della parola porta all’inevitabile estinzione del designato. Allo stesso modo, l’abuso assennato porta alla violazione del significato.
Amo la lingua inglese, quando per certi termini utilizza vocaboli diversi, laddove in italiano ne abbiamo uno solo. Solitudine, per esempio, viene espresso con solitude e loneliness. Il primo suggerisce il piacere legato alla solitudine, il secondo al dolore provato in condizioni di esclusione e isolamento involontario. Dunque cos’è la solitudine? Mancanza di affetti? E’ una condizione o uno stato d’animo? Forse la solitudine è nebbia. Ho affittato una macchina. So ancora guidare. Guidare è come andare in bicicletta. Non te lo dimentichi. Ma a differenza del treno o del bus, non puoi leggere o scrivere, perché devi guidare. Già. Camminando hai una visuale a trecentosessanta gradi sul mondo e molteplici stimoli. Guidare obbliga a focalizzare il mondo all’interno di uno spettro visivo molto più limitato. Guidare è un po’ come restare fermi sulle proprie posizioni, pur muovendosi, procedendo in una direzione, ma è difficile poter vagliare altri punti di vista. Camminare, invece, è un po’ come avere una discussione aperta e critica con il mondo. Insomma è un po’ come paragonare una conversazione al caffè con la collega di Tecnologia, a una cena a lume di candela con la Marianni di Arte. E poi, agli occhi di un semplice uomo, alcune cose restano un mistero. Ammetto di aver visto donne che alla guida erano in grado di parlare al telefonino, accendersi una sigaretta e contemporaneamente mettersi il rossetto senza sbavarlo e senza guardarsi nello specchietto. Miracoli del multitasking tutto femminile. La Marianni non so. Non si imbelletta quasi mai e ha un cellulare dei Flinstone, motivo che mi fa pensare che non lo usi poi così tanto, tanto meno in auto, anche perché lei usa la bicicletta, ma è un’ottima interlocutrice. Per quanto mi riguarda io sto guidando e questo impegna già abbastanza le mie abilità.
 Sto percorrendo la statale in direzione sud. E’ freddo. Freddo umido. Quel freddo del nord che non dà speranza in un raggio di sole che cambi le sorti della giornata. All’ improvviso divento solo pensiero: la linea di mezzeria è sparita, quelle di delimitazione della strada anche. Davanti, il nulla. Cerco nello specchietto retrovisore. Altro nulla. Il nulla si spalanca sull’infinito. Lo spazio prima occupato dai riferimenti materiali della massa delle cose, viene abrogato antidemocraticamente e il tempo si ferma. Anzi si azzera. Ogni esperienza pregressa si vanifica. In questa bolla senza orizzonte alcuno, si vanifica il senso dell’orientamento, tale solo in uno spazio delimitato, per quanto grande che sia. Fallace il riferimento, fallace la relazione con il mondo circostante, divento il centro di un nuovo universo che inizia e finisce con la mia persona. Percezione che si identifica con il perimetro della mia carne. Anch’essa fallace: perde repentinamente consistenza per non aver più alcun riferimento altro da sé. E dunque già non è. Si acutizzano i sensi, ma nel nulla, anche i sensi, così castrati, girano a vuoto. Nessun ritorno cui aggrapparsi per produrre reazioni diverse dalla stasi. Solo l’olfatto trova un vago appiglio infantile, dolce e vanigliato: è l’odore della nebbia. Poi, al ricordo, subentra repentino il pensiero razionale, che invece corre a mille, vaglia ogni possibilità. Ma esse sono infinite e il pensiero diventa infinito. Puro. Irrazionale. E nell’infinità irrazionale diventi nessuno. Nella mancanza di identificazione in qualcosa, scopri la tua limitatezza, non avvezzi a misurarci con l’umana inadeguatezza. Oppure, il suo sommo contrario. Dipende dai punti di vista. E’ l’umana condizione. L’umana solitudine. Poi vedo il sole che splende sulla mia rocciosa costa ligure e penso che quello è il mio posto. Ma forse è solo un’allucinazione. Altro infinito mi attende, ma mi è più familiare: l’orizzonte mare. Là, dove la prospettiva si fonde e disorienta, chi non si perde, ritrova la propria collocazione caduca e divina. Mina, la vastità acquea, la certezza. Ridimensiona la pupilla. La collera cessa. S’annega l’arroganza. Danza l’umana piccolezza, svelando fibre di coscienza, omessa per negligenza reiterata. È il risveglio di inorganici sensi: il Pensiero, la Poesia, il Rapimento. Null’altro che importi al mare. Null’altro che necessiti il perituro, in ragion del quale, del tempo, la linea, là vi si confonde. E poi il botto.
Sto percorrendo la statale in direzione sud. E’ freddo. Freddo umido. Quel freddo del nord che non dà speranza in un raggio di sole che cambi le sorti della giornata. All’ improvviso divento solo pensiero: la linea di mezzeria è sparita, quelle di delimitazione della strada anche. Davanti, il nulla. Cerco nello specchietto retrovisore. Altro nulla. Il nulla si spalanca sull’infinito. Lo spazio prima occupato dai riferimenti materiali della massa delle cose, viene abrogato antidemocraticamente e il tempo si ferma. Anzi si azzera. Ogni esperienza pregressa si vanifica. In questa bolla senza orizzonte alcuno, si vanifica il senso dell’orientamento, tale solo in uno spazio delimitato, per quanto grande che sia. Fallace il riferimento, fallace la relazione con il mondo circostante, divento il centro di un nuovo universo che inizia e finisce con la mia persona. Percezione che si identifica con il perimetro della mia carne. Anch’essa fallace: perde repentinamente consistenza per non aver più alcun riferimento altro da sé. E dunque già non è. Si acutizzano i sensi, ma nel nulla, anche i sensi, così castrati, girano a vuoto. Nessun ritorno cui aggrapparsi per produrre reazioni diverse dalla stasi. Solo l’olfatto trova un vago appiglio infantile, dolce e vanigliato: è l’odore della nebbia. Poi, al ricordo, subentra repentino il pensiero razionale, che invece corre a mille, vaglia ogni possibilità. Ma esse sono infinite e il pensiero diventa infinito. Puro. Irrazionale. E nell’infinità irrazionale diventi nessuno. Nella mancanza di identificazione in qualcosa, scopri la tua limitatezza, non avvezzi a misurarci con l’umana inadeguatezza. Oppure, il suo sommo contrario. Dipende dai punti di vista. E’ l’umana condizione. L’umana solitudine. Poi vedo il sole che splende sulla mia rocciosa costa ligure e penso che quello è il mio posto. Ma forse è solo un’allucinazione. Altro infinito mi attende, ma mi è più familiare: l’orizzonte mare. Là, dove la prospettiva si fonde e disorienta, chi non si perde, ritrova la propria collocazione caduca e divina. Mina, la vastità acquea, la certezza. Ridimensiona la pupilla. La collera cessa. S’annega l’arroganza. Danza l’umana piccolezza, svelando fibre di coscienza, omessa per negligenza reiterata. È il risveglio di inorganici sensi: il Pensiero, la Poesia, il Rapimento. Null’altro che importi al mare. Null’altro che necessiti il perituro, in ragion del quale, del tempo, la linea, là vi si confonde. E poi il botto.
Forse sono morto. Inizio a vaneggiare. Ma la luce là in fondo non è quella in fondo al tunnel, ma quella della sirena dell’ambulanza. Mi ritrovo al San Martino di Genova che è già buio pesto e con una prognosi non proprio riservata, ma nemmeno tanto pubblica, visto che non lo sa nessuno. E un’operazione d’urgenza per rimettermi a posto qualche ossicino forse di non vitale importanza. Almeno sono a casa. Cioè almeno sono a Genova, anche se non propriamente all’indirizzo sperato. Ora mi tocca dire a mia madre che non sarò a casa per cena.
“ Tornare a Genova è diverso, a Genova tornerò volentieri perché Genova è mia moglie” scrisse da qualche parte Fabrizio De André, che a Genova alla fine tornava sempre, come me del resto.
Tornare a Genova è diverso, a Genova tornerò volentieri perché Genova è mia moglie” scrisse da qualche parte Fabrizio De André, che a Genova alla fine tornava sempre, come me del resto.
Eccola la mia città. La Fenice Superba. Con spasmi di un’esistenza asmatica, l’uomo del secondo millennio si affanna ai popolari broncodilatatori eroga-illusioni, come i maiali alle mammelle della scrofa. Risucchiata in pochi pollici, la città operosa perde la sua identità. Perde il gesto. Perde la parola. Miope, sotterranea, si declina negli sguardi liquidi, assenti, della vacuità virtuale. È la fermata del metrò. Lontana ere esistenziali dalla grandezza “regale per uomini e per mura” che ne fece la Superba di petrarchiana memoria. Alcuni lo chiamano Progresso. Io, Decentramento Esistenziale. Ma è il Mare, solo il Mare, esigente d’attenzione, a riscattare il valore, a ristabilire l’equilibrio, riempiendo, ad ogni fugace contatto, gli occhi svuotati, con rinnovata vastità. Genova è salva! Ancora una volta! E può celebrare se stessa!
Dilaga la piazza al mare che addensa le navi/ inesausto/ Ride l’arcato palazzo rosso del portico grande:/ Come le cateratte del Niagara/ Canta, ride, svaria ferrea la sinfonia feconda/ urgente al mare: /Genova canta il tuo canto! (Dino Campana)
(Fotografie dell’amica Raffaella Maini)