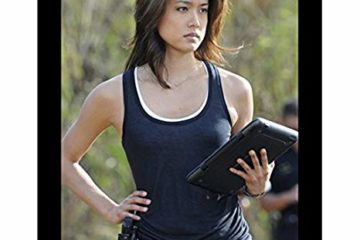Mai copertina fu più felice. Un inno alla mia “ligurietà”…In primo piano..la tangenziale in ora di punta ![]() 😉 Include il racconto “Le canne non crescono sugli alberi”.
😉 Include il racconto “Le canne non crescono sugli alberi”.
“LE CANNE NON CRESCONO SUGLI ALBERI”
Genova è una città strana. È una città bella, brutta, grande, piccola, di mare, di montagna. Sicuramente molto contraddittoria e di grande fascino. Dipende dai punti di vista. Genova è la mia città d’infanzia. Non è solo il porto, o il lungomare di palme e belle ville, non è solo la focaccia calda del mattino. Genova è i suoi vicoli stretti, promiscui e maleodoranti, che ad ogni angolo ti stupiscono con una qualche opera d’ arte nascosta e inaspettata. Basta alzare lo sguardo e puoi imbatterti in una delle centinaia di miracolose edicole votive, per lo più barocche, che ornano gli angoli degli alti palazzi che quasi si toccano e scrutano il viandante che ha sempre la testa bassa, intento a dribblare escrementi. Forse proprio questa è la Bellezza. La Bellezza è nell’imperfezione perfetta.
I vicoli offrono di tutto, e per noi studenti di altri quartieri, erano il luogo non luogo dell’iniziazione, dove affrontare e superare le nostre paure, dove sfidare le raccomandazioni genitoriali e mettere alla prova i nervi. Soprattutto i vicoli più abietti, quelli dello spaccio. Noi studentelli universitari della Genova bene e di studi umanistici ci facevamo di “Confessioni di un mangiatore d’oppio” come De Quincey dalla mattina alla sera, quando l’oppio non sapevamo neanche cosa fosse, di sicuro una sostanza stupefacente antica e quando gli unici fiori che ci sbarellavano l’intelletto erano “I fiori del male” di Baudelaire. Assurdo, come assurdo l’accanimento per cercare di capire il senso del teatro dell’assurdo. Beckett ci aveva messo in guardia. Eppure ognuno continuava ad aspettare il suo Godot. Qualcuno lo cercava anche. I vicoli, ecco proprio i vicoli, ci offrivano una fetta reale di tutto ciò che ci serviva per dare un senso a certi versi. Per questo erano la meta favorita delle nostre scorribande serali. Fare finta di esserne diventati habitué ci dava l’impressione di essere intoccabili esattamente come i suoi variopinti abitanti. Ma era solo un’impressione, e il nostro, un mero atteggiamento.
“Che fate stasera? A me ste prove di Casa di bambola mi hanno distrutto”.
“A proposito, dobbiamo ripassare anche tutto Beckett per l’esame di Storia del Teatro”.
“Io devo andare a studiare letteratura inglese per l’esame di dopodomani”.
“Io mi farei una bella canna, invece”.
“Sì, eccolo! E dove la trovi! A Castelletto al massimo ti puoi fare un gelato al pesto! E io non voglio finire nei casini”
“Che vuoi che sia, fa meno male di quella roba che trovi dal tabacchino. E poi stimola la concentrazione. Non siamo più ragazzini. Eccheccazzo!”
“Sarà…ma se lo sanno i miei mi fanno un mazzo tanto! E poi io non fumo nemmeno sigarette, lo sai”.
“Dai, prova. So io dove trovarla. Andiamo! Ma fatevi vedere convinti. Mettiamo cinquemila lire a testa e via. Con ventimila lire ci facciamo un bel cannone”.
Max era l’unico che nei vicoli c’ era nato e cresciuto veramente. Mica faceva finta di conoscerli, lui.
Scendemmo dal trono della città alta con il leggendario ascensore liberty già caro a Giorgio Caproni. Lui ci voleva salire per andare in paradiso, noi ci scendevamo negli inferi. Poi da Via Garibaldi giù per Vico Angeli, Via della Maddalena, e poi mi perdo, ma sicuramente la gerarchia di santità scendeva man mano che ci si addentrava nel dedalo del centro storico più grande d’Europa. Questo negli anni ottanta, prima del centenario di Colombo e quando i vicoli erano il bronx cittadino e si pensava che l’Aids si prendesse anche solo guardandosi negli occhi. Non vivo a Genova da un pezzo. Mi dicono che oggi quei vicoli vanno di moda, come l’aperitivo con l’assenzio e l’iphone 6.
Più si scendeva e ci si inoltrava in quegli inferi maleodoranti, più il fetore si acutizzava: piscio di cane, merde spalmate per metri da passanti distratti, la cui scia incerta e barcollante doveva essere frutto dei piedi di un ubriacone, cocci di vetro, spazzatura che faceva bella mostra di sé con gli articol

i più curiosi. Da un vecchio televisore a tubo catodico totalmente distrutto, faceva capolino la resistenza di una lavatrice, e intorno, sacchi di immondizie neri, meglio conosciuti come rumenta e lacerati dai gatti che ne avevano sparso il contenuto. Un presepe di rifiuti degno di un’inst
allazione temporanea della biennale di Venezia, dove, a dire il vero, ho pagato per vedere anche di peggio.
Seguivo a passo sicuro la ‘cumpa’, ma non mi sentivo per niente sicuro. Mi sforzavo di non accelerare l’andatura per non tradire il disagio. Ero in zona off limits, nella tela del ragno. Non ero mai stato in quella parte di vicoli. Di certo non dopo le ventidue. Il cuore batteva e temevo potesse risuonare in quella cassa armonica amplificata che sono i vicoli di notte. Camminavo con lunghe falcate per stare dietro agli altri e per non dare a vedere che facevo fatica a stare dietro al loro passo, sgambettando invece come una ragazzetta fuori luogo, Mi imposi di respirare profondamente, a testa alta, pancia in dentro e spalle larghe, per darmi un tono. Ero vissuto pe
r qualche tempo a Londra, bazzicato Camden Town e la zona nord, eppure, i vicoli quella sera mi facevano accapponare la pelle. Forse aveva iniziato anche a piovere, ma i palazzi erano così vicini che non capivo bene. O forse era solo qualcuno che stava pisciando dalla finestra.
“Eccolo! Ci parlo io. Tu poi gli dai la grana”, fece a me, che tenevo la cassa comune nella tasca del paltò nero, e alludendo alla sagoma appoggiata ad un portone antico. Era un marocchino alto di statura e d
i età indefinita e sguardo liquido.
Max ci parlò a due dita dal naso quasi bisbigliando. Lui mi guardò come infastidito e Max fece cenno ai soldi. Mi avvicinai, allungai la mano verso il marocchino che come un gioco di prestigio fece sparire i soldi e materializzò un pezzetto di corteccia marrone di un centimetro e mezzo, nel palmo della mia mano. Lo guardai e stavo per buttarlo via, quando Max me lo scippò abilmente, prendendo se
nza una parola, la via del ritorno.
“Che roba è sta specie di corteccia, Max. Non vorrai dirmi che abbiamo speso ventimila lire per un pezzo di legno che trovo in giardino!”.
“Tesoro, forse d
a voi in Albaro siete così snob che ve le vendono già arrotolate in un cofanetto naj oleari, oppure vi crescono sugli alberi. Ma qui no. Dammi, ci penso io. E se la infilò in tasca”.
Dalle stalle alle stelle. Il percorso a ritroso fu invece al passo veloce di chi si sente seguito da un branco di cani affamati. In realtà, ci bastava l’idea di uno sbirro. Giù per Vico qualcosa, su per vico qualcos’altro e poi vicolo di qualche santo che non mi ricordo di aver mai sentito né mai percorso nemmeno all’andata, e quindi a sinistra in via di un qualche mestiere artigiano ormai dimenticato.
Mi girava la testa, ma cercavo di concentrarmi solo
a mettere una gamba dopo l’altra nel minor tempo possibile. Tuttavia senza che diventasse correre. Finalmente mi ritrovai in zone più familiari. E infine l’ascensore per il paradiso.
Di fatto ne uscì un cannone che condividemmo tutti, e per questa ragione, essendo in quattro, con due tiri a testa per due giri, la corteccia si fumò in un lampo, lasciandoci esattamente come eravamo prima. A bocca asciutta. Per quanto mi riguarda io che non sapevo nemmeno fumare, aspirai e buttai fuori nell’arco di un nano secondo quella roba dolciastra, tra un accidente e l’altro dei miei
compagni di viaggio.
“Sei uno spreco. E tira, no?”, mi urlò qualcuno.
Solo a Max parve fare un qualche effetto, o forse era proprio lui così. Due tiri e chiuse gli occhi per qualche istante, poi alzò il volto a fissare in silenzio il grande pino marittimo che con le sue fronde sembrava
proteggerlo dal troppo cielo. Non riusciva ad abituarcisi proprio. Il cielo gli faceva male. Era troppo aperto il cielo di Castelletto, diceva sempre. Rimbaud scriveva: “Voglio essere poeta, lavoro a rendermi Veggente: lei non ci capirà niente, ed io quasi non saprei spiegarle. Si tratta di arrivare all’ignoto mediante la sregolatezza di tutti i sensi. Le sofferenze sono enormi, m
a bisogna essere forti, essere nati poeti, e io mi sono riconosciuto poeta. Non è colpa mia. È falso dire “Io penso” si dovrebbe dire “Mi si pensa”. Scusi il gioco di parole: IO è un altro”.
Forse Max era l’unico veggente. Era sempre alla ricerca di qualcosa e a volte sembrava vederla oltre senza mai poterla toccare. Era un sognatore, malgrado fosse con i piedi per terra più di tutti noi. Mi è sempre piaciuto pensarlo come il Veggente del secondo millennio, ma al secondo millennio n
on ci arrivò per un pelo. Aveva ottimi voti. Ma non finì nemmeno l’università. Morì di overdose un pomeriggio che pioveva che Dio la mandava. Nessuno di noi sapeva che si bucava.
Nessuno di noi sapeva veramente chi fosse Max. Ma a me fece conoscere la Bellezza.