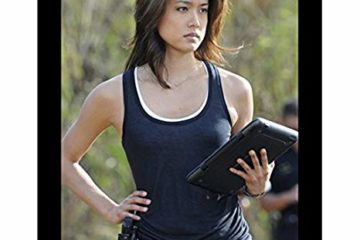(testo di Stefania Contardi. Fotografie Antonio Gregolin)
Tutte le scarpe hanno una storia
che ne precede la propria memoria
Hanno un passato, hanno un futuro,
e anche se incerto e insicuro,
l’unità di misura non è il tempo ma il passo,
che siano alla moda o nel tempo a spasso.
Contengono i sogni ancor prima dei piedi
e te lo assicuro, anche se non lo chiedi,
esse conoscono con certezza
ciò di cui oggi, ancora, non hai saggezza.
Le scarpe, sì, hanno una loro mente. Una saggezza congenita, connaturata. Hanno un ruolo e sul suolo un’identità precisa, una dimestichezza innata. Nascono con un proprio destino, una propria funzione. In azione sono tali e muoiono felici per lento declino. Inclini al proprio utilizzo, sempre sul pezzo, avvezze in quanto mezzo, anche quando solo per diletto. Fa un grande effetto, però, quando è il contrario: le scarpe soffrono se entrano nel limbo del disuso, preferendo l’uso profuso al non aver espletato affatto, il compito profferto. Afflitte per negligenza, che tristezza, se per leggerezza vengono abbandonate prima del tempo, sapendo di aver potuto perdurare ancora oltre il qui e ora. Perché ancora prima di essere possedute, s’impossessano di una storia. Affini ai sogni di un paio di piedi, chiediti se sono le scarpe che possiedono i piedi e non viceversa. Emersa è la questione e squisita è la risposta. La posta è assecondarne il potere di decretare il successo o l’insuccesso di percorsi, di gesta, del raggiungimento di mete intime o audaci. E delle gesta, resta la memoria segreta o popolare, spirituale o temporale a celebrare di ognuno la storia, anche oltre l’umana memoria del proprio tempo, che, lento, ne dimentica il valore e la morale.
Fa male doverle ricordare in quei cumuli osceni, pieni di dignità perduta, dove fottuta è l’intera storia e d’obbligo la rimembranza di quanti, concentrati in quella stanza, l’hanno lasciata vuota senza passare da porta alcuna, né da finestra. Mesta, la maestra lo ricorda agli scolari ignari di quei truci allestimenti. Le piccole menti non ne portano memoria e, datemi retta, di quei calzari, nemmeno i martiri loro proprietari. Al pari, di Caporetto, già racconta come fu costretto a indietreggiare sugli scarponi chiodati l’Esercito Regio. Non fu un pregio né un privilegio, inciampando ad ogni passo a ritirar sul Piave lasciando allo scarpone nemico il Friuli e il Veneto settentrionale.
Ilari, preferisco pensarle a far baldoria nella locanda a buon prezzo, sotto al tavolone grezzo, le scarpacce grezze e grosse, ben ingrassate dalle risate degli avventori che si avventano sulla soppressa, bella grassa pure quella. O sul buon vino rosso. Menando per la campagna, a turno, il terno di compagnie di piedi instabili, di cui conoscono a menadito la via del ritorno. Storto. Oppure forgiate in attesa del primo passo, cullano il sogno del ragazzo, della ragazza civettuola, del contadino attento o del direttore attento solo alla moda e della prossima sposa.
Sandali, stivali, stivaletti, scarpe, scarpette, ciabatte e decolté. Sono le scarpe che, passo dopo passo, han fatto la storia o che nella storia han fatto. Di fatto: di pelle, di cuoio, di legno, di cartone, chiodate, ferrate, impolverate, con le suole rinforzate, rattoppate, ingrassate a dovere, lucidate, sponsorizzate dal sovrano di turno, con il tacco a rocchetto rococò, con il tacco a spillo, con il tacco senza tacco, con il tacco a tocchi nel tombino, da riattaccare ha il ciabattino. Cenerentola nella zucca va a zappare zoppa con la zeppa. Con il tacco basso il successo è riscosso. Con il velcro svelto, o con il cinturino, sottile o spesso, con il passante, con la cerniera, con la punta a punta o la punta spuntata, la punta squadrata o arrotondata, la pianta larga, o dalla mole allargata, la pianta stretta che morde la fretta di arrivare all’appuntamento. E, lento, si forma il callo del ballo, bel bello, per assecondar la grazia della ballerina muta al dolore che la strazia, tra un pliet, un balzo e una piroetta. Per ore e ore nella scarpetta, sempre troppo dura, sempre troppo stretta. Difficile immaginare il sangue e il sudore, tutte quelle ore, per arrivare alle punte, danzando in siffatta leggerezza, assuefatta a simulazione, la prima ballerina. E quell’altra? Della signorina agghindata a festa? Dalla finestra ascolta il vociare indistinto fuori da Messa e s’appresta a sfoggiare con vezzo la scarpetta domenicale che, visto il prezzo, viene tramandata per tradizione, di generazione in generazione, con la venerazione di chi può permettersene un paio per famiglia, passandola di figlia in figlia, noncurante della fattezza, della grandezza del piede ospitato e inospitale. E che male! Che sfrontatezza, la bellezza comunicale. Comunicare con il passo lento, lasso o frettoloso, non oso pensare a quanto dimostro di me stessa quando le indosso. Ma se posso permettermi una considerazione, la tensione di ogni passo registra spesso la scarpa addosso. Lo leggi nel cuoio, nelle pieghe, se lieve è il passo o nella suola consunta da un lato, se non fai perno e rulli il tallone come un pallone, ma lo trascini, strisci e strascichi con noncuranza per la stanza in una malsana danza. Faccio istanza ufficiale per ricompensare quelle scarpe nuove che, a partire dalle suole, sanno cedere la propria rigidità all’insistenza del piede in una sorta di resa, tesa ad un empatico avvicinamento con la forma infine presa, mostrando sulla tomaia di pelle l’ossuto alluce valgo e nodoso. Il riposo, non trovano nemmeno le suole delle ciabatte sciatte delle madri mezze sfatte, che piazzano sermoni a destra e a manca per il disordine della figlia, che se qualcuno se la piglia non ha fatto un grande affare. E continua ad imprecare.
E poi il passo si fa sicuro, su per il terreno duro del Grappa, lungo il sentiero smosso e poi indurito dal gelo, lo scarpone montanaro si avventura su per l’erta, sempre all’erta sul versante irto, franoso, ispido e irriconoscente. Ma lui non mente ché ha memoria del paesaggio e il passaggio conosce bene, dalla vetta a punta all’alpeggio, il peggio evitando dei massi franosi, dei sassi che scarta, dribbla, spunta, avvezzo a queste terre di mezzo dal vento percosse, fosse anche solo perché percorse spesso. Oppure rosso di sangue, sporco finito nel fango, finito nel fosso, affonda fino in fondo, seguendo fedele, il giovane mosso da amor di patria che lo ha venduto a un fato ingrato e che lo consuma fino all’osso. Là nel fosso, la sua fossa. Là sul dosso, l’ultima Messa, mentre lentamente muore con un’intera generazione, la nazione. Dalla trincea con disamore, procrastinando a vita (o a morte) la propria sorte ancora forte di soli vent’anni, lo stivaletto in vacchetta con puntale resta, perché persa è la battaglia e con essa ogni guerra quando lieve sulla terra è il giovane piede, ormai.
Guai! A non ricordare anche l’albero nodoso che ha ceduto di sé stesso un bel pezzo solido e spesso per gli zoccoli piccoli e rozzi di una mocciosa con i boccoli. Ecce homo con riluttanza avanza nella stanza zeppa di arazzi, la scarpetta di velluto rosso del baldanzoso cardinale. O con l’abito talare si fa avanti il polacchino nero, lucido e stringato del ministro officiante i diversi sacramenti, come richiesti dall’istante. Fermo restante che non sempre è una festa, che quella del morire è una gran bella scocciatura. Beninteso, per chi resta. Un adempimento ingrato, un’incombenza. Ci vuole pazienza. Resilienza. Sconvolge i piani quotidiani, ma anche l’agenda di domani: chiamare tutti nel cuore della notte, di sotto sentono, aspettiamo le sette. Ma che te ne fotte, chiamiamolo adesso, io non aspetto. Squilla il telefono come un ossesso. Il prete, il dottore e tutti i parenti, l’impresa funebre e fare due conti: i necrologi. E i fiori? Rose rosa o garofani rossi? Il vestito e le scarpe! Non badiamo alle marche, certo le scarpe per l’ultimo viaggio devono avere le suole nuove. Come vuole tradizione. Quindi si cerchino ovunque le migliori, le più belle, quelle di pelle, quelle dannatamente strette. Presto! Sono già le sette. Tanto non sente un bel niente il piede del morto. Non hai torto. E poi cercare il tutto nero. È vero! E la scarpa sobria, nera, che, a capo chino, fa capolino dallo scaffale. Ed è tale per non dar troppo nell’occhio, per confondersi nel mucchio, per dichiarare il proprio lutto, quando tutto, in realtà, non ha valore per nessuno. E poi tutti al funerale, tutti appresso alla processione, la scarpa nera regola il passo, che sia di effetto, che dimostri affetto, commovente ma non troppo, liturgico un pochino, ma non troppo o troppo ostentato, troppo triste o manierato, troppo lungo o troppo corto. Perché nel giorno più funesto, questo è il tono in barba al defunto già vestito di tutto punto. Perché tutto deve essere ineccepibile, impeccabile, irreprensibile, perfetto, per rispetto, quando, invece, rispetto alla morte, ironia della sorte, tutto risulta inadatto, inappropriato, imbarazzante, persino la vita sua consorte. Dillo forte! Persino le scarpe! Non è il fato ma un destino in cui è unito l’essere umano. Chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Tutti al passo verso il trapasso. Che poi, se Dio vuole, chiuso il coperchio e su un bel sasso. Ma con l’epigrafe e la bella foto, è noto, e che sia almeno di vent’anni e dei malanni non vi sia segno. Pegno, quella foto con l’alone sembra sempre tanto un sogno. Come è giusto forse che sia. Occhio non vede e cuor non duole, suole il tempo lenire e curare, azzittire tutte le pene. Ebbene, quando muoio, qui lo dico e lo confermo, fermo che l’inevitabile non lo so evitare, io vi penso e vi dispenso dagli oneri onerosi, dagli onori delle onorificenze. Non sentitevi obbligati, non sentitevi sbagliati, dite e fate ciò che volete, tanto io mica vi sento e poi non ci sento neanche tanto. E non mento, continuate la vostra vita quotidiana che sia sana o dissipata, vivetela adesso a più non posso. Solo un fesso chiederebbe un permesso per esser dove io solo io posso, solo un po’ più in giù nel fosso. E col fosso, lo capite che tutto ciò non ha alcun nesso? Lacrime, ricordi, sentimentalismi, quelli lasciateli agli scrittori, ai poeti, ai cantautori ché non è roba di questo mondo. In fondo, pensate a vivere meglio, a vivere qui, a vivere adesso, vivete spesso, con meno cemento, meno affanno. Dannazione! È passato un altro anno! Meno obblighi e più piacere. E le sere, godetevi i tramonti, passeggiate per i monti. I ponti, riallacciateli in vita e non dopo. Lo scopo è meno petrolio che puzza e più bellezza dentro ai pozzi. Siete pazzi, non fatevi fessi, non cercate la felicità nei fossi, raccoglietela nei passi, raccoglietela tra i sassi. Inseguitela con lena come un cane dietro all’osso, fosse che fosse ne trovate un pezzo, lì nel mezzo. Poi sparpagliatela nel mondo, bene e a fondo, perché, in fondo, là sul fondo, poi non serve più a nessuno. Ma ad ognuno una cosa chiedo, e visto il suo gusto per l’imprevisto potrebbe essere ora o tra un bel pezzo, mica ve la chiedo dopo, ve la chiedo adesso. Quando passo e ci penso spesso, festeggiate, fate baldoria, che passiate tutti alla storia, vestite le scarpe della festa, rosso cresta di gallina, oppure quelle da ginnastica bianche da corsa, con le borchie, con gli strass o gli stivaletti con le cinghie, strafogatevi di meringhe, di mandorlato per merenda, di focaccia alla mia faccia, mangiate a sbafo, bevete a sbuffo, sporcatevi i baffi, fate il trenino, ballate il mambo, giocate a tombola, ricordando che chi fa ambo non fa bingo, per cui puntate a razzo al rampazzo. E poi, ultimo ma non meno importante, delle mie scarpe fate man bassa. Fatelo a più non posso; io più non posso, dato il trapasso. Prendetele tutte che ne ho a iosa, non è noiosa ma orgogliosa la mia enorme scarpiera. Fiera negli anni ha raccolto fogge e utilizzi vari, mode imperfette, scarpe distrutte o quelle comprate per l’occasione o anche solo d’ occasione comprate: e chi le mette al mattino alle sette le scarpe laccate col tacco a spillo? E dillo! Che è una sciocchezza, che il piede è a pezzi per l’utilizzo. Robe da pazzi. Ma è da un pezzo che ci penso e almeno quel giorno voglio essere all’altezza. Quindici centimetri possono bastare. Avranno il loro momento di gloria e poi eterno sarà l’oblio, senza dubbio, senza inganno, senza aver recato danno. Non saranno le Coco Chanel, le Jimmy Choo, le Laboutine ma di satine e di velluto, col tacco a stiletto e le piume di struzzo. Resteranno tutti di stucco. Questo è il trucco, senza inganno, che con affanno e molto danno nemmeno ci riesci a camminare. Scarpe feticcio, da fotogramma, testimonial del nulla che avanza, scarpe gioiello per una foto sull’auto sportiva del baronetto che le scarrozza di qua e di là, da un galà a un party ma non all’altare. Non ci sperare. Presto rinchiuse in una teca a mostrare la propria inutilità di un frammento di vita insulsa e ostentata. Vita dannata. Esse lo sanno è il loro destino: per un momento di gloria, un veloce declino.
Perché le scarpe non sono scarpe se non hanno fatto il loro percorso, se non hanno morso il proprio terreno, se non lo hanno almeno rincorso. Se, insomma, nel bene o nel male, non hanno una storia da raccontare. E se è nel bene, bene, se è nel male, male. Restano a ricordare che, ahimè, l’uomo non è proprio ad imparare incline. Fine.